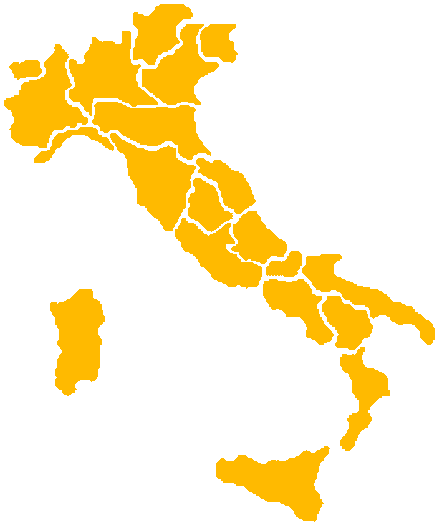Dal sito della Giustizia Amministrativa
Adunanza Plenaria n. 5/2020 pubblicata il 18.02.2020
Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione – Sine titulo – Art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 – Applicabilità.
Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione – Sine titulo – Obbligo di restituzione derivante da giudicato civile – Imposizione servitù di passaggio – Preclusione per giudicato civile o amministrativo – Esclusione.
L’art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, e dunque quale che sia la ragione che abbia determinato l’assenza di titolo che legittima alla disponibilità del bene (1).
Il giudicato restitutorio (amministrativo o civile), inerente all’obbligo di restituire un’area al proprietario da parte dell’Amministrazione occupante sine titulo, non preclude l’emanazione di un atto di imposizione di una servitù, in esercizio del potere ex art. 42 bis, comma 6, DPR 8 giugno 2001 n. 327, poiché questo presuppone il mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare (2).
Le questioni sono state rimesse dalla sez. IV con ord. 15 luglio 2019, n. 4950.
(1) Ha chiarito a Sezione che la verifica della “compatibilità” del decreto di acquisizione ex art. 42- bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con un giudicato restitutorio, in specie formatosi su sentenza del giudice civile dichiarativa della nullità di un contratto di compravendita (o, se si preferisce, la possibilità di esercizio del potere ex art. 42-bis pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che ordina la restituzione del bene), presuppone la previa risoluzione del problema costituito dall’ambito di applicazione del medesimo art. 42-bis (se esso possa, cioè, applicarsi anche in ipotesi diverse da quelle ritenute dalla sentenza impugnata) di modo che:
– se si considera tale disposizione applicabile (come vuole l’ordinanza) “ad ogni caso in cui – per qualsiasi ragione – un bene immobile altrui sia utilizzato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico”, allora (e solo allora) potrà verificarsi se, più specificamente, il potere conferito dall’art. 42 bis potrà essere esercitato anche in presenza di un giudicato restitutorio (e, ancor più specificamente, come nel caso di specie, in presenza di una sentenza declaratoria della nullità di un contratto di compravendita);
– se, invece, si considera l’art. 42 bis limitato “solo a vicende in cui la P.A. agisce nella sua veste di autorità” (come sostiene la sentenza impugnata), allora appare evidente come nessuno dei quesiti posti dall’ordinanza di rimessione potrebbe essere esaminato nel merito (e tantomeno ricevere risposta nei sensi prospettati dall’ordinanza).
In definitiva, la prospettazione dei quesiti così come articolata si fonda su un presupposto (l’ambito “ampio” di applicazione dell’art. 42 bis), assunto come “acquisito”, mentre esso deve essere oggetto di necessaria verifica nella presente sede.
E ciò anche al fine di evitare che – non esaminando tale presupposto logico-giuridico dei quesiti espressamente formulati – si possa pervenire ad una implicita (e dunque non chiara) adesione, da parte della Adunanza Plenaria, alla tesi della positiva sussistenza di quello che si è definito l’ambito “ampio” di applicazione dell’art. 42 bis (la cui applicabilità potrebbe essere eventualmente esclusa per ragioni specifiche, ma non per una sua propria limitazione ontologica).
In conclusione, occorre, innanzi tutto, definire l’ambito di applicazione dell’art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, anche al fine, come si è detto, di scrutinare il primo motivo di appello (sub lett. a) dell’esposizione in fatto
Così impostata la questione sottoposta a giudizio, l’Adunanza Plenaria ritiene che l’art. 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) trovi applicazione in tutti i casi in cui un bene immobile altrui sia nella disponibilità e sia stato utilizzato dall’amministrazione pubblica per finalità di pubblico interesse, pur in assenza di titolo.
Adunanza Plenaria (sent. 9 febbraio 2016 n. 2) ha già affermato come l’art. 42 bis “introduce una norma di natura eccezionale” e che l’acquisizione ivi prevista “costituisce una delle possibili cause legali di estinzione di un fatto illecito”.
Tale articolo “configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo”.
La natura di “norma di chiusura”, propria dell’art. 42-bis – desumibile anche dai principi (ora riportati) già espressi da questa Adunanza Plenaria – rende evidente la finalità di ricondurre nell’alveo legale del sistema tutte le situazioni in cui l’amministrazione, quale che ne sia la causa, si trovi ad avere utilizzato la proprietà privata per ragioni di pubblico interesse, ma in difetto di un valido titolo legittimante.
Ne consegue che il dato letterale della norma non osta all’applicazione dell’art. 42 bis nelle ipotesi in cui il difetto di titolo si manifesti per intervenuta declaratoria di nullità ovvero per annullamento del contratto di compravendita.
La possibilità di consentire l’applicazione dell’art. 42 bis (e, quindi, del decreto di acquisizione) in tutte le ipotesi in cui – come sostenuto dall’ordinanza di rimessione – “per qualsiasi ragione un bene immobile altrui sia utilizzato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico”, oltre a non essere impedita dal dato letterale della disposizione, risulta coerente anche con un inquadramento logico-sistematico della disposizione medesima, nell’ambito di una più generale riflessione sull’attività amministrativa e sugli strumenti ad essa inerenti.
A fronte del testo dell’art. 42 bis che richiede che l’utilizzazione sine titulo del bene deve essere comunque intervenuta “per scopi di interesse pubblico”, giova ricordare che l’attività della pubblica amministrazione risulta costantemente funzionalizzata alla cura, tutela, perseguimento dell’interesse pubblico, sia che a tali fini vengano esercitati poteri pubblicistici ad essa conferiti – e dei quali l’interesse pubblico costituisce, al tempo stesso, la causa dell’attribuzione e la giustificazione dell’esercizio in concreto – sia che vengano utilizzati strumenti propri del diritto privato, in un contesto generale già delineato attraverso l’esercizio di potestà pubbliche.
Tale affermazione, che può essere ritenuta ormai principio acquisito dall’ordinamento, trova il suo riscontro nell’art. 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, che, nell’enunciare i “principi generali dell’attività amministrativa”, prevede che la stessa si effettui sia mediante l’esercizio di poteri autoritativi, sia ricorrendo ad istituti di diritto privato (“salvo che la legge non disponga diversamente”).
L’azione amministrativa che si concretizza nell’emanazione di provvedimenti amministrativi, ovvero quella che si svolge, in forma paritetica, attraverso la sottoscrizione di accordi con i soggetti privati (art. 11, l. n. 241 del 1990, in particolare attraverso gli accordi sostitutivi di provvedimento), così come la stessa azione che utilizza direttamente strumenti disciplinati dal diritto privato (in specie, contratti), partecipa dell’unica (ed unificante) ragione di interesse pubblico, che la sorregge e giustifica., rappresentandone la causa in senso giuridico.
Con la precisazione che, mentre nelle prime due ipotesi le finalità di pubblico interesse sono implicite nello stesso ricorso ad atti “tipici”, quali il provvedimento amministrativo o l’accordo (procedimentale o sostitutivo), nella terza ipotesi il ricorso ad atti di diritto privato (e, segnatamente, contratti tipici e nominati previsti dal codice civile) in tanto può essere ricondotta all’ambito di una azione amministrativa funzionalizzata, in quanto essa si iscriva, anche in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa, in un contesto di finalità di interesse pubblico, previamente definito mediante l’esercizio dei poteri all’uopo occorrenti e obiettivamente accertabile.
Proprio tale più generale immanenza dell’interesse pubblico, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quella di natura provvedimentale, ha già fatto più volte affermare alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2017 n. 2256, 19 agosto 2016 n. 3653, 3 dicembre 2015 n. 5510; sez. V, 5 dicembre 2013 n. 5786; sez. V, 14 ottobre 2013 n. 5000), la irriducibilità degli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990 a meri “strumenti di matrice civilistica”.
Si è a tal fine osservato che “fermi i casi di contratti di diritto privato (per i quali trovano certamente applicazione le disposizioni del codice civile), nei casi invece di contratto ad oggetto pubblico l’amministrazione mantiene comunque la sua tradizionale posizione di supremazia; tali contratti non sono disciplinati dalle regole proprie del diritto privato, ma meramente dai “principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti”, sempre “in quanto compatibili” e salvo che “non diversamente previsto”.
Orbene, alle ipotesi costituite da accordi tra amministrazione e privati – e specificamente accordi sostitutivi aventi contenuto patrimoniale (cui, secondo una definizione comunemente invalsa, può attribuirsi il nomen di “contratti ad oggetto pubblico”, in quanto disciplinanti aspetti patrimoniali connessi all’esercizio di potestà: v. Cons. Stato, sez. IV, n. 2256/2017 cit.) – ben possono affiancarsi le ipotesi in cui l’amministrazione stipuli contratti di diritto privato in un quadro che – pur non caratterizzato dallo svolgimento di un procedimento amministrativo o in sostituzione di questo – risulta tuttavia già delineato dal precedente esercizio di poteri pubblici, con i quali si è già provveduto ad individuare le finalità di pubblico interesse da perseguire.
Con riguardo ai cd. contratti ad oggetto pubblico ed ai cd. contratti ad evidenza pubblica, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di osservare (Cons. Stato, sez. IV, n,. 2256/2017 cit.) come la finalità di pubblico interesse ne determini diversamente il contenuto.
Nei primi (contratti ad oggetto pubblico), la predetta finalità “non costituisce (né lo potrebbe) una “immanenza” esterna alla convenzione/contratto, ma essa – in quanto la Pubblica Amministrazione persegue sempre nella sua azione interessi pubblici, in conformità al principio di legalità, quale che sia il modulo utilizzato – conforma il contratto medesimo, ed in particolare – proprio in ragione delle definizioni che il diritto privato ne offre – gli elementi essenziali della causa e dell’oggetto”.
Nei secondi (contratti ad evidenza pubblica) – laddove non è presente una regolazione degli aspetti patrimoniali dell’esercizio della potestà, ma sono presenti solo procedimenti antecedenti al contratto, volti ad individuare il soggetto contraente con la pubblica amministrazione – tuttavia “una volta scelto il contraente, il contratto stipulato successivamente alla fase di evidenza pubblica non rifluisce “immediatamente” nella più generale disciplina del codice civile e delle ulteriori disposizioni che eventualmente regolano il rapporto patrimoniale consensualmente instaurato tra privati. Ciò è a tutta evidenza negato dalla stessa presenza di una (copiosa) disciplina speciale che normalmente assiste il momento genetico e quello funzionale del contratto, e che non può che giustificarsi se non in ragione della “particolare natura” dello stesso; laddove tale “particolare” natura non è costituita dall’esservi la pubblica amministrazione quale soggetto contraente, bensì dall’essere la causa e l’oggetto del contratto differentemente conformati, in ragione delle finalità di interesse pubblico perseguite con il contratto, e dunque con l’adempimento delle obbligazioni assunte per il tramite delle rispettive prestazioni (a seconda dei casi, l’opus o il servizio)”.
In definitiva, nei casi in cui la pubblica amministrazione – dopo avere individuato per il tramite di un generale e preventivo atto di esercizio di potestà, anche in ossequio al principio di legalità, la finalità di pubblico interesse – decida di perseguire quest’ultima non già attraverso procedimenti amministrativi tipici ed esercizio di poteri provvedimentali, bensì ricorrendo a ordinari modelli privatistici (nei limiti consentiti dall’ordinamento), la predetta finalità di interesse pubblico resta immanente al contratto ed al rapporto così posto in essere.
Ciò comporta, di conseguenza, che, laddove la finalità di pubblico interesse non risulta (o non risulta più) essere perseguita (o perseguibile) per il tramite del contratto, non può escludersi, in generale, che l’amministrazione possa intervenire sul rapporto insorto (ovvero sulle conseguenze di fatto di un rapporto comunque cessato) per il tramite dell’esercizio di poteri pubblicistici.
Non può, dunque, condividersi la sentenza impugnata laddove essa afferma che sarebbe contrario “ai principi costituzionali e sovranazionali consentire alla P.A. che agisce in veste di contraente privato di mutare in corso di rapporto la natura del potere speso, perché ciò attribuirebbe alla parte pubblica un privilegio confliggente quantomeno con gli artt. 3 e 42 Cost.”.
(2) Ha chiarito l’Alto consesso che perché possa prodursi l’effetto preclusivo derivante dal giudicato restitutorio, occorre che la sentenza preveda espressamente, in accoglimento di una specifica domanda avanzata in tal senso dal ricorrente o dall’attore, la condanna dell’amministrazione alla restituzione del bene; per altro verso, l’effetto preclusivo, in quanto derivante, come si è detto, da una espressa condanna alla restituzione del bene, si realizza con riguardo al provvedimento ex art. 42 bis, comma 2, comportante l’acquisizione dello stesso alla proprietà pubblica (in particolare, al patrimonio indisponibile della medesima) e non può, quindi, inibire anche l’adozione del diverso provvedimento di imposizione di servitù, di cui al successivo comma 6.
Quanto a questo secondo aspetto, la sentenza coperta da giudicato in senso sostanziale, ex art. 2909 c.c., fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi) e il bene della vita che ne forma oggetto (cd. petitum mediato).
Appare, dunque, evidente come, se oggetto del petitum è il recupero del bene alla piena proprietà e disponibilità del soggetto privato originariamente proprietario, non rientra nell’ambito oggettivo del giudicato, e dunque non si pone in contrasto con lo stesso, un provvedimento che, senza incidere sulla titolarità del bene, imponga sullo stesso ex novo (e, quindi, ex nunc) una servitù, trattandosi di ipotesi affatto diversa da quella inibita dal giudicato e assolutamente coerente con, e anzi presupponente, il mantenimento della proprietà in capo al privato.